“Era una cosa
molto comune: uno che lavorava con i poveri era comunista… E anche se non è
vero, sono già tutti convinti, è già scritto che i preti che lavorano con i
poveri sono comunisti”. Queste parole fanno parte della deposizione che l’8
novembre 2010 il cardinale Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos
Aires e oggi papa Francesco, fece alla Corte argentina che indagava sui crimini
della dittatura militare. In particolare la Corte si stava occupando delle
torture e dei delitti perpetrati nella Escuela
superior de mecánica de la Armada,
la scuola degli ufficiali della Marina militare argentina a Buenos Aires, dove
erano stati tenuti sotto sequestro e tormentati due religiosi della Compagnia
di Gesù, della quale all’epoca dei fatti, nel 1977, Bergoglio era il padre
provinciale.
In
quell’interrogatorio, pubblicato ora nel libro di Nello Scavo, “La lista di
Bergoglio, i salvati da Francesco durante la dittatura”, il cardinale di Buenos
Aires spiegava che questa idea per la quale tutti i preti che operavano per i
poveri sarebbero stati comunisti, era presente in Argentina anche prima
dell’avvento del regime militare; né l’accusa di comunismo colpiva solo i
cristiani che seguivano quel filone della “teologia della liberazione” che si
diceva facesse ricorso a un’ermeneutica marxista: non era questa la posizione
dei gesuiti perseguitati dal regime militare, secondo l’arcivescovo di Buenos
Aires, né si poteva far risalire unicamente al Concilio Vaticano II il fatto
che vi fossero preti particolarmente impegnati con i poveri, come i cosiddetti
“curas villeros” (preti delle
baraccopoli). In realtà, diceva
Bergoglio,
“la scelta dei poveri
risale ai primi secoli del cristianesimo. È nello stesso Vangelo. Se io oggi
leggessi come omelia alcuni dei sermoni dei primi Padri della Chiesa, del
II-III secolo, su come si debbano trattare i poveri, direste che la mia omelia
è da marxista o da trotzkista. La Chiesa ha sempre onorato la scelta di
preferire i poveri. Considerava i poveri il tesoro della Chiesa. Durante la
persecuzione del diacono Lorenzo che era amministratore della diocesi, quando
gli chiesero di portare tutti i tesori della Chiesa, si presentò con una marea
di poveri e disse: “Questi sono i tesori della Chiesa”[1]…
Durante il Concilio Vaticano II si riformulò la definizione della Chiesa come
popolo di Dio ed è da lì che questo concetto si rinforza e, nella seconda
Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano a Medellin, si trasforma nella forte identità
dell’America Latina”.
Quel prete e
vescovo argentino, divenuto papa, continua a predicare nello stesso modo, a
rischio dell’accusa di marxismo e trotzkismo: e non solo perché, al momento
dell’elezione, un suo amico cardinale, il brasiliano Hummes, gli disse: “ricordati dei poveri”, ciò per
cui lui decise di chiamarsi Francesco. Lo fa perché “la scelta dei poveri viene
dal Vangelo”, come ha detto ai giudici argentini. Per la Chiesa il Vangelo è
come la Costituzione per una Repubblica, è la legge fondamentale che legittima
o invalida tutte le altre leggi; e come un capo di Stato deve stare alla
Costituzione, per non essere trovato infedele, così un papa deve stare al
Vangelo, se non vuole tradire la sua missione.
Il passo
avanti che ha fatto Francesco è di affermare che la scelta dei poveri che sta
nel Vangelo, e che perciò lo impegna come papa, sta anche nella Costituzione
del mondo, nel “dover essere” del mondo, e perciò lo impegna anche come uomo e
come papa non alienato dal mondo. Lo ha detto a Cagliari, il 23 settembre 2013,
nel momento stesso in cui esortava gli operai, i cassintegrati, i disoccupati a
non farsi “rubare la speranza e la dignità” insieme col lavoro, ad avere coraggio, a pregare il Signore Gesù
di dar loro il lavoro e di insegnar loro “a lottare per il lavoro”. Ha detto di
non volere che quel suo invito fosse solo “una bella parola di passaggio”,
fosse “soltanto un sorriso di impiegato cordiale della Chiesa”: “devo fare di
tutto perché non sia così”, ha detto, devo impegnarmi “come pastore e come
uomo” per sostenere questo coraggio, per rivendicare insieme ai lavoratori “un
sistema giusto, non questo sistema economico globalizzato, che ci fa tanto
male”.
Nessuna
alienazione, dunque; questo è un papa che ai poveri del mondo non vuole dare
oppio, ma pane, lavoro e salvezza. L’idea, religiosa e politica, è che se i
poveri periscono, tutto il mondo perisce. E sia chiaro che non si tratta di una
scelta populista, fatta per guadagnare consensi, per accrescere gli adepti
della Chiesa. Il papa stesso ha detto nell’omelia a Santa Marta dell’11 giugno,
che l’annuncio non è proselitismo, fatto “con cuore di investimento”: “per
quella strada non si va da nessuna parte; il Signore ci ha inviato ad
annunziare non a fare proseliti”. E lo ha ripetuto nell’intervista a Scalfari
del 1 ottobre 2013: “il proselitismo è una solenne sciocchezza…Il nostro obiettivo non è il
proselitismo ma l’ascolto dei bisogni, dei desideri, delle delusioni, della
disperazione, della speranza. Dobbiamo ridare speranza ai giovani, aiutare i
vecchi, aprire verso il futuro, diffondere l’amore. Poveri tra i poveri.
Dobbiamo includere gli esclusi e predicare la pace”.
La scelta dei poveri negli atti di papa
Francesco
Per questa
ragione vale la pena indagare in che modo questa scelta di campo per i poveri
si è specificata e articolata fino ad ora negli atti e nelle parole del governo
papale di Francesco.
Quanto agli
atti, essi sono di straordinaria eloquenza. Anzitutto per l’identificazione dei
poveri che non sono i “poveri in spirito” ma ricchi di beni, come vorrebbe
un’interpretazione disincarnata del vangelo di Matteo, bensì sono i poveri
reali: i profughi e i sommersi di Lampedusa, i carcerati, i senzatetto delle
baraccopoli, i disoccupati, i precari, i sottopagati, gli ammalati, i disabili,
gli anziani lasciati soli e i giovani senza futuro.
Gli atti sono
poi quelli con cui vengono scelti i luoghi dell’incontro con i poveri, che non
sono i luoghi dove i ricchi giocano in casa e ricevono gli indigenti, e nemmeno
le aule delle udienze generali, ma sono i luoghi dove vivono e soffrono i
poveri, dove bisogna andare a trovarli: il mare di Lampedusa, le favelas, le carceri, gli ospedali, gli
ospizi, le mense.
Atti sono pure
quelli che nei poveri riconoscono non solo i bisogni primari ed elementari, ma
anche quelli relazionali e affettivi, come quando il papa incarica un suo
inviato, l’arcivescovo Konrad Krajevski, di distribuire ai naufraghi scampati
all’ecatombe di Lampedusa del 3 ottobre insieme a un consistente aiuto in
denaro a ciascuno, anche le schede telefoniche per comunicare con i loro cari.
E atti sono
anche quelli che nell’etica del rapporto privilegiato della Chiesa con i poveri
perseguono la trasparenza dello IOR e delle finanze vaticane, magari invidiando
Pietro che, come ha detto il papa l’11 giugno a Santa Marta, “non aveva un
conto in banca”, tanto che per pagare le tasse dovette andare a prendere il
denaro nella bocca di un pesce; e un atto esemplare è anche l’allontanamento
del vescovo di Limburg che spende una quantità di soldi per il lusso del suo
episcopio.
La guerra evitata
Atti sono
anche quelli con cui il papa ha inteso risparmiare alla Siria e a tutto il
Medio Oriente i tormenti di un’altra guerra, estranea ad ogni ragione. Anche
questo vuol dire salvare la carne del povero. “Lavorare per edificare la pace”
è in effetti uno dei tre punti programmatici del pontificato che papa Francesco
aveva voluto notificare agli ambasciatori venuti ad incontrarlo il 22 marzo,
subito dopo la sua elezione, per uno scambio di saluti in cui egli aveva voluto
vedere “idealmente l’abbraccio del papa al mondo”. Il primo punto
programmatico, che egli diceva legato alla scelta del nome Francesco, era
quello di “lottare contro la povertà,
sia materiale, sia spirituale”. Il secondo punto, legato alla “seconda ragione”
del suo nome, era appunto quello di “lavorare per edificare la pace”. E il
terzo punto era quello di “costruire ponti fra tutti gli uomini, così che
ognuno possa trovare nell’altro non un nemico, non un concorrente, ma un
fratello da accogliere ed abbracciare”.
È nel
perseguimento del secondo punto del suo programma, condizione del resto anche
del primo e del terzo, che papa Francesco si è subito imbattuto nel precipizio
del minacciato bombardamento americano e francese alla Siria. E come papa
Giovanni, imbattutosi nella crisi dei missili a Cuba, all’inizio del Concilio,
mise tutto se stesso nell’impegno di scongiurare la guerra, così papa
Francesco, all’inizio del suo pontificato, ha messo tutto se stesso nello
sforzo di evitare l’attacco alla Siria; e tutte e due le volte tali interventi
sono stati efficaci. La prima volta Giovanni XXIII si rivolse a Kennedy e a
Krusciov attraverso un messaggio alla radio; questa volta papa Francesco si è
rivolto a Putin ad Obama e agli altri leaders mondiali mediante una lettera al G
20 di San Pietroburgo, e non solo, ma anche mediante una straordinaria
mobilitazione popolare sotto le forme della preghiera e del digiuno. E come la
prima volta ne venne poi fuori uno dei più straordinari documenti del magistero
pontificio, la Pacem in terris, che
riguardo alla guerra giusta, ai diritti, alla pari dignità della donna, alla
libertà di coscienza, al costituzionalismo e all’ONU faceva fare alla Chiesa un
balzo innanzi nella dottrina e nella pastorale, così questa volta ne è venuta
fuori una delle più alte azioni pastorali del ministero pontificio, la veglia
di quattro ore dei centomila in piazza san Pietro, che riguardo al rapporto tra
papa e popolo, tra parola e silenzio, tra devozione privata e liturgia pubblica
e tra preghiera inerme e politica armata, ha dato alla Chiesa un’esperienza di
fede quale forse non aveva mai
avuto. E come la prima volta l’intervento papale ebbe
l’immediato riscontro della promessa del ritiro dei missili da Cuba, così
questa volta ha ottenuto l’immediata promessa della consegna all’ONU delle armi
chimiche in Siria.
Ma al di là
delle analogie tra i due eventi, c’è una novità da rilevare questa volta, ed è
la concretezza politica dell’intervento di papa Bergoglio, che non ha evitato
di entrare nel merito dello scontro, per destituire di senso la guerra sul
piano della legittimità e dell’efficacia, dopo averla oppugnata sul piano umano
e religioso.
I contenuti propriamente
politici dell’iniziativa di papa Francesco, si possono ricavare da diverse
fonti. La prima è naturalmente la lettera a Putin, come leader della
Federazione russa e presidente del vertice di San Pietroburgo. Vi si legge che
il papa denuncia gli “interessi di parte” che impediscono di trovare una
soluzione che eviti “l’inutile massacro a cui stiamo assistendo”, e invita i
capi degli Stati del G20 a non rimanere inerti di fronte alle sofferenze della
popolazione siriana e ad abbandonare “ogni vana pretesa di una soluzione
militare”; il papa chiede inoltre alle potenze del
mondo di affrontare "con rispetto della persona umana e dei più
deboli" la crisi economica globale.
C’è poi la
fonte del discorso fatto agli ambasciatori in Vaticano quella stessa mattina
del 5 settembre dal Segretario per i Rapporti con gli Stati, mons. Dominique
Mamberti, in cui alla condanna per l’impiego di armi chimiche che avevano
colpito la popolazione civile in Siria il 21 agosto, si accompagnava l’auspicio
che si facesse chiarezza e fossero chiamati a rendere conto alla giustizia i
responsabili, che dunque si supponeva non coincidessero col governo siriano.
Inoltre il rappresentante della Santa Sede dichiarava assolutamente prioritario
far cessare la violenza e indicava tre criteri per la soluzione del conflitto:
1) ripristinare il dialogo tra le parti e operare per la riconciliazione del
popolo siriano; 2) preservare l’unità del Paese evitando la costituzione di
zone diverse per le varie componenti della società; 3) garantire l’unità e
l’integrità territoriale del Paese stabilendo nel principio di cittadinanza la
pari dignità di tutti senza differenze di etnie o di religioni.
C’è poi
l’intervista del generale dei Gesuiti, padre Adolfo Nicolàs, che si può
supporre esprimesse, quello stesso giorno, il pensiero del papa gesuita. Egli
negava il diritto degli Stati Uniti e della Francia ad agire contro un Paese
che aveva già tanto sofferto, e affermava che l’intervento militare in
preparazione costituiva un abuso di potere: “Gli Stati Uniti d’America devono
smettere di comportarsi e reagire come il fratello maggiore del quartiere del
mondo”; diceva poi che finché non si accertasse chi avesse usato le armi
chimiche, si poteva dubitare che gli Stati Uniti avessero “altri motivi per il
previsto intervento” e aggiungeva infine di non poter accettare “che un Paese
che si considera almeno nominalmente cristiano in una situazione di conflitto
non possa concepire altro che l’azione militare e con essa portare il mondo
nuovamente alla legge della giungla”.
Infine c’è l’
“Angelus” dell’8 settembre, la mattina successiva alla veglia in piazza san
Pietro. Parlando della
parabola evangelica sulla guerra il papa diceva come “in questo momento in cui stiamo fortemente
pregando per la pace” quella parola invitava a “una guerra più profonda che
dobbiamo combattere” che “comporta dire no all’odio fratricida e alle menzogne
di cui si serve; dire no alla violenza in tutte le sue forme; dire no alla
proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. Ce n’è tanto! Ce n’è
tanto! E sempre rimane il dubbio: questa guerra di là, quest’altra di là è
davvero una guerra per problemi o è una guerra commerciale per vendere queste
armi nel commercio illegale?”,
contestazione, questa, avanzata dai pacifisti in tutte le guerre.
La critica di sistema nelle parole di papa
Francesco
Accanto agli
atti in cui finora il papa Francesco ha riversato la sua scelta dei poveri e il
suo impegno per la pace, ci sono le parole in cui è andato tessendo la trama
del suo pontificato, di ciò che ci vuole dire e di ciò che vorrebbe fare.
Queste parole vanno interrogate per vedere se al di là dello sguardo
caritatevole verso il povero, e della lode per la pace, c’è un giudizio che
arriva ad identificare le ragioni della povertà e le cause strutturali della
guerra, e se al di là delle perorazioni di cui è stata prodiga in passato la
cosiddetta “dottrina sociale cristiana”, ossia il magistero pontificio in
materia sociale, si arriva qui a una critica di sistema e ad un’istanza di
cambiamento di sistema.
La lettura dei
testi ci dice che proprio di questo si tratta; ma allora il problema che
immediatamente si pone è se a questa istanza di cambiamento, ispirata dalle
ragioni supreme cui il papa si appella e che lasciano aperta la questione del
“che fare”, possano corrispondere dottrine politiche, teorie e prassi
economiche, leggi e Costituzioni, azioni e lotte politiche che tocca a noi mettere
in campo; e c’è da chiedersi che cosa facciamo noi perché questo cambiamento si
possa produrre. È una domanda importante perché è da tempo che la sinistra ha
smesso di porsi la questione di un’alternativa di sistema.
Fin
dall’inizio il papa ha dato un nome al sistema da cui gli esseri umani sono
oggi schiacciati, l’ha identificato nella globalizzazione e ne ha descritto i
fondamenti e gli esiti; e fin dall’inizio ha posto il problema delle
“periferie” create da tale sistema, “dove
c’è sofferenza, c’è sangue versato, c’è cecità che desidera vedere, ci sono
prigionieri di tanti cattivi padroni”, come ha detto il 28 marzo nella prima “messa crismale”
celebrata come vescovo di Roma.
“Il denaro deve servire e non governare”
Il giudizio
più severo il papa lo ha dato già il 16 maggio, due mesi dopo la sua elezione; anche
in questa occasione parlava a dei diplomatici, ma questa volta, curiosamente,
parlava a rappresentanti di piccolissimi Paesi venuti a presentargli le
credenziali, i nuovi ambasciatori del
Kyrgyzistan, di Antigua e Barbuda, del Botswana e del Gran Ducato di
Lussemburgo, Paesi che, a parte il Lussemburgo, solo dal 1992, dal 1981 o dal
’66 siedono all’ONU: a loro, come se si trovasse davanti all’assemblea delle
Nazioni Unite, il papa ha fatto un grande discorso di analisi e di prospettiva,
che prendeva in carico ciò che la Chiesa latinoamericana già aveva chiamato
“non un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca”:
“Signori Ambasciatori, l’umanità vive in questo momento
come un tornante della propria storia, considerati i progressi registrati in
vari ambiti. Dobbiamo lodare i risultati positivi che concorrono all’autentico
benessere dell’umanità, ad esempio nei campi della salute, dell’educazione e
della comunicazione. Tuttavia va anche riconosciuto che la maggior parte degli
uomini e delle donne del nostro tempo continuano a vivere in una precarietà
quotidiana con conseguenze funeste. Alcune patologie aumentano, con le loro
conseguenze psicologiche; la paura e la disperazione prendono i cuori di
numerose persone, anche nei Paesi cosiddetti ricchi; la gioia di vivere va
diminuendo; l’indecenza e la violenza sono in aumento; la povertà diventa più
evidente. Si deve lottare per vivere, e spesso per vivere in modo non
dignitoso. Una delle cause di questa situazione, a mio parere, sta nel rapporto
che abbiamo con il denaro, nell’accettare il suo dominio su di noi e sulle
nostre società. Così la crisi finanziaria che stiamo attraversando ci fa
dimenticare la sua prima origine, situata in una profonda crisi antropologica.
Nella negazione del primato dell’uomo! Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione
dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,15-34)
ha trovato una nuova e spietata immagine nel feticismo del denaro e nella
dittatura dell’economia senza volto né scopo realmente umano.
“La crisi mondiale che tocca la finanza e l’economia
sembra mettere in luce le loro deformità e soprattutto la grave carenza della
loro prospettiva antropologica, che riduce l’uomo a una sola delle sue
esigenze: il consumo. E peggio ancora, oggi l’essere umano è considerato egli
stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo
incominciato questa cultura dello scarto. Questa deriva si riscontra a livello
individuale e sociale; e viene favorita! In un tale contesto, la solidarietà,
che è il tesoro dei poveri, è spesso considerata controproducente, contraria
alla razionalità finanziaria ed economica. Mentre il reddito di una minoranza
cresce in maniera esponenziale, quello della maggioranza si indebolisce. Questo
squilibrio deriva da ideologie che promuovono l’autonomia assoluta dei mercati
e la speculazione finanziaria, negando così il diritto di controllo agli Stati
pur incaricati di provvedere al bene comune. Si instaura una nuova tirannia
invisibile, a volte virtuale, che impone unilateralmente e senza rimedio
possibile le sue leggi e le sue regole. Inoltre, l’indebitamento e il credito
allontanano i Paesi dalla loro economia reale ed i cittadini dal loro potere
d’acquisto reale. A ciò si aggiungono, oltretutto, una corruzione tentacolare e
un’evasione fiscale egoista che hanno assunto dimensioni mondiali. La volontà
di potenza e di possesso è diventata senza limiti”
“Dietro questo atteggiamento si nasconde il rifiuto
dell’etica, il rifiuto di Dio. Proprio come la solidarietà, l’etica dà
fastidio! È considerata controproducente: come troppo umana, perché relativizza
il denaro e il potere; come una minaccia, perché rifiuta la manipolazione e la
sottomissione della persona. Perché l’etica conduce a Dio, il quale si pone al
di fuori delle categorie del mercato. Dio è considerato da questi finanzieri,
economisti e politici, come non gestibile, Dio non gestibile, addirittura
pericoloso perché chiama l’uomo alla sua piena realizzazione e all’indipendenza
da ogni genere di schiavitù. L’etica – un’etica non ideologica naturalmente –
permette, a mio parere, di creare un equilibrio e un ordine sociale più umani.
In questo senso, incoraggio gli esperti di finanza e i governanti dei vostri
Paesi a considerare le parole di san Giovanni Crisostomo: «Non condividere con
i poveri i propri beni è derubarli e togliere loro la vita. Non sono i nostri
beni che noi possediamo, ma i loro» (Omelia
su Lazzaro, 1, 6 : PG 48, 992D).
“Cari Ambasciatori, sarebbe auspicabile realizzare una
riforma finanziaria che sia etica e che produca a sua volta una riforma
economica salutare per tutti. Questa tuttavia richiederebbe un coraggioso
cambiamento di atteggiamento dei dirigenti politici. Li esorto ad affrontare
questa sfida, con determinazione e lungimiranza, tenendo conto naturalmente
della peculiarità dei loro contesti. Il denaro deve servire e non governare!...
La Chiesa, da parte sua, lavora sempre per lo sviluppo integrale di
ogni persona. In questo senso, essa ricorda che il bene comune non dovrebbe
essere una semplice aggiunta, un semplice schema concettuale di qualità
inferiore inserito nei programmi politici. La Chiesa incoraggia i governanti ad
essere veramente al servizio del bene comune delle loro popolazioni. Esorta i
dirigenti delle realtà finanziarie a prendere in considerazione l’etica e la solidarietà. E
perché non potrebbero rivolgersi a Dio per ispirare i propri disegni? Si
formerà allora una nuova mentalità politica ed economica che contribuirà a
trasformare la dicotomia assoluta tra la sfera economica e quella sociale in
una sana convivenza”.
Come si vede
non si tratta di una pia esortazione, ma di una visione antropologica (il
destino dell’uomo!) che mette radicalmente in causa l’attuale assetto economico
e politico, depreca il dominio incondizionato del denaro, denuncia la dittatura
e la tirannia invisibile di un’economia senza volto né scopo veramente umano, critica
l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria, imputa
all’economia monetaria di deprimere l’economia reale della società e il potere
d’acquisto reale dei cittadini e rivendica il diritto di controllo degli Stati,
invocando una riforma finanziaria ed etica che renda di nuovo gestibile il
mercato e produca una riforma economica salutare per tutti.
La cultura dello scarto
Il papa è poi
tornato più volte a tematizzare la “cultura dello scarto”. Il mondo di
quest’epoca nuova non è concepito, non è pensato per tutti. Esso è dominato dal
denaro, che è selettivo. “Uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del
profitto e del consumo: è la cultura dello scarto”, ha detto Francesco il 5
giugno in piazza san Pietro; e più volte ha citato un midrash (commento scritturistico) ebraico che, a proposito della
torre di Babele, diceva che se si rompeva un mattone d’argilla tutti facevano
un grande pianto, ma se un operaio cadeva dall’impalcatura e moriva, nessuno si
preoccupava. Dalla torre di Babele a via Ottaviano. Diceva il papa:
“Se una notte d’inverno
qui vicino, in via Ottaviano per esempio, muore una persona, quella non è una
notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare,
quella non è una notizia, sembra normale. Se si rompe un computer è una
tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per
entrare nella normalità. Che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per
la strada non fa notizia. Al contrario un abbassamento di dieci punti nelle
borse di alcune città costituisce una tragedia. Così le persone vengono
scartate come se fossero rifiuti”.
L’8 luglio il papa è andato
a Lampedusa, e ha posto in tutta la sua portata il problema della
globalizzazione, identificata come causa di quelle tragedie:
“Oggi questa domanda
emerge con forza: Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e
sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, io non c’entro, saranno
altri, non certo io…; e con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La
cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende
insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono
belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che
porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione
dell’indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella
globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. Ritorna la
figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione dell’indifferenza ci
rende tutti “innominati”, responsabili senza nome e senza volto. «Adamo dove
sei?», «Dov’è tuo fratello?», sono le due domande che Dio pone all’inizio della
storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo,
anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: «Chi di noi ha
pianto per questo fatto e per fatti come questo?», chi ha pianto per la morte
di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla
barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che
desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che
ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire con”: la globalizzazione
dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere… Chiediamo perdono per
l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo, Padre, perdono per
chi si è accomodato, si è chiuso nel proprio benessere che porta all’anestesia
del cuore, ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello
mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi”.
Più tardi, nel viaggio di ritorno dal
Brasile, rievocando la visita a Lampedusa, il papa ribadiva ai giornalisti che
in gioco c’era “il sistema”:
“Quando arrivano queste
barche li lasciano alcune miglia prima della costa e loro devono, con la barca,
arrivare da soli. E questo mi fa dolore perché penso che queste persone sono
vittime di un sistema socio-economico mondiale”.
Un sistema economico-sociale iniquo
Il tema della
globalizzazione e del sistema economico-sociale iniquo era stato largamente
sviluppato in tutto il viaggio in Brasile per la Giornata mondiale della
Gioventù (24-28 luglio 2013).
Ai giovani argentini, il
25 luglio:
“Guardate, io penso che in questo momento questa civiltà mondiale
sia andata oltre i limiti, perché ha creato un tale culto del dio denaro che
siamo in presenza di una filosofia e di una prassi di esclusione dei due poli
della vita che sono le promesse dei popoli. Esclusione degli anziani,
ovviamente. Uno potrebbe pensare che ci sia una specie di eutanasia nascosta,
cioè non ci si prende cura degli anziani, ma c’è anche un’eutanasia culturale,
perché non li si lascia parlare, non li si lascia agire. E l’esclusione dei
giovani. La percentuale che abbiamo di giovani senza lavoro, senza impiego, è
molto alta e abbiamo una generazione che non ha esperienza della dignità
guadagnata con il lavoro”.
Nella visita alla favela di Varginha (25 luglio):
“Nessuno può rimanere insensibile alle diseguaglianze che ancora
ci sono nel mondo… Non è la cultura dell’egoismo,
dell’individualismo,che costruisce e porta a un mondo più abitabile… Desidero
incoraggiare gli sforzi che la società
brasiliana sta facendo per integrare tutte le parti del suo corpo, anche le più
sofferenti e bisognose, attraverso la lotta contro la fame e la miseria… Non
lasciamo entrare nel nostro cuore la ‘cultura dello scarto’, perché noi siamo
fratelli, nessuno è da scartare”.
All’episcopato brasiliano
(27 luglio):
“La globalizzazione implacabile e l’intensa urbanizzazione spesso
selvagge, hanno promesso molto. Tanti si sono innamorati delle loro
potenzialità e in essa c’è qualcosa di veramente positivo come, per esempio, la
diminuzione delle distanze, l’avvicinamento tra le persone e le culture, la
diffusione dell’informazione e dei servizi. Ma, dall’altro lato, molti vivono i
loro effetti negativi senza rendersi conto di come essi pregiudicano la propria
visione dell’uomo e del mondo, generando maggiore disorientamento, e un vuoto
che non riescono a spiegare…Davanti a questo panorama serve una Chiesa che
accompagna il cammino, mettendosi in cammino con la gente….”
Ai vescovi e sacerdoti
venuti a Rio per accompagnare i giovani alla “Giornata mondiale” (27 luglio): Siamo chiamati, diceva,
“a promuovere la cultura dell’incontro. Purtroppo, in molti
ambienti, si è fatta strada una cultura dell’esclusione, una ‘cultura dello
scarto’. Non c’è posto né per l’anziano né per il figlio non voluto; non c’è
tempo per fermarsi con quel povero sul bordo della strada. A volte sembra che
per alcuni i rapporti umani siano regolati da due ‘dogmi’ moderni: efficienza e
pragmatismo. Abbiate il coraggio di andare controcorrente”.
Si potrebbero citare
molte altre parole del papa che scavano nelle stesse profondità, mettendo in
guardia contro i compromessi e proponendo scelte radicali. Così come nella
veglia per la pace del 7 settembre, quando il papa ha escluso, per così dire,
il riformismo spicciolo, proponendo invece una netta alternativa: non si può
mettere d’accordo un po’ di armonia e un po’ di disarmonia; “possiamo dire che
dall’armonia si passa alla ‘disarmonia’? No, non esiste la ‘disarmonia’, o c’è
armonia o si cade nel caos, dove è violenza, contesa, scontro, paura…”. Allo
stesso modo vanno respinti i giustificazionismi onde cerchiamo di rendere
ragionevoli la violenza e la guerra: “abbiamo perfezionato le nostre armi, la
nostra coscienza si è addormentata, abbiamo reso più sottili le nostre ragioni
per giustificarci. Come se fosse una cosa normale, continuiamo a seminare
distruzione, dolore, morte! La violenza, la guerra, portano solo morte, parlano
di morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte!”
Naturalmente la risposta
è cercata soprattutto in direzione di una conversione delle persone, di una
rivoluzione etica, di un’azione evangelizzatrice della Chiesa, ma non mancano
riferimenti molto precisi anche a risposte di carattere economico, giuridico e
politico. Come a Cagliari quando il papa si mette con gli operai ad opporsi a
“una scelta mondiale di un sistema economico” che porta alla tragedia della
mancanza di lavoro e “che ha al centro un idolo, che si chiama denaro”. O come
nella risposta a Scalfari:
“Personalmente penso che il cosiddetto liberismo selvaggio non
faccia che rendere i forti più forti, i deboli più deboli e gli esclusi più
esclusi. Ci vuole grande libertà, nessuna discriminazione, non demagogia e
molto amore. Ci vogliono regole di comportamento ed anche, se fosse necessario,
interventi diretti dello Stato per correggere le diseguaglianze più
intollerabili”.
Si, è necessario; e
l’appello alle regole di comportamento è in realtà l’appello al diritto, alle
norme e alle garanzie delle Costituzioni, all’economia politica che sottopone
alla ragione e all’utilità sociale la finanza e l’iniziativa economica pubblica
e privata, all’intervento dello Stato; tutte cose che stanno scritte nel
costituzionalismo democratico moderno, che l’Europa ha abbandonato o sta
abbandonando e che proprio in questi anni si stanno invece scoprendo ed
attuando in America Latina.
La novità di un papa che
si chiama Francesco potrebbe forse rappresentare il catalizzatore che inneschi
di nuovo in Europa un processo di liberazione di questo tipo. Ieri, al tempo
del Concilio, al tempo del discorso di Togliatti a Bergamo, al tempo in cui con
Claudio Napoleoni scrivevamo la “lettera ai comunisti” per “l’uscita dal
sistema di dominio e di guerra”, il problema centrale era il pericolo di una
guerra nucleare e il vincolo di un sistema globale che su di essa era fondato e
da essa era garantito. Oggi il problema della salvezza degli
esseri umani e del mondo da loro custodito, passa attraverso la minaccia
rappresentata dal culto idolatrico del denaro, e da un sistema economico
improntato a un liberismo selvaggio che rende i forti più forti, i deboli più
deboli, e gli esclusi più esclusi. Esso
ha bisogno di un amore che curi le ferite, restituisca la dignità dell’avere un
lavoro, annunci il perdono e sconfigga la cultura dello scarto. E per questo è
apparso un papa che si chiama Francesco.
Il compito
che perciò oggi ci è dato è che finalmente dobbiamo rovesciare l’idolo,
dobbiamo desacralizzare e addomesticare il denaro. Il papa ha detto più volte
di essersi ispirato, fin dalla sua giovinezza, al quadro di Caravaggio sulla
vocazione di Matteo, che egli andava a vedere durante i suoi studi romani nella Chiesa di San
Luigi dei francesi. Tra le varie figure del quadro egli identificava Matteo non
nel vecchio con la barba, come la maggior parte dei critici, ma nell’uomo
giovane – il pubblicano - che cerca di difendere il denaro come un bottino:
proprio ciò che Gesù veniva a disturbare con la sua chiamata.
La chiamata
che oggi è rivolta non solo a Matteo, ma a tutti, è di non trattare il denaro
come un bottino. Noi non possiamo più vivere in un mondo il cui padrone, il cui
sovrano, il cui pantocrator, il cui
idolo è il denaro. Il denaro è necessario perché senza denaro, come dice l’Apocalisse,
non si può né comprare né vendere, cioè non si può vivere. Però il mondo non
può essere fondato sul denaro. Perché se è fondato sul denaro non può essere
fondato sul lavoro, come vorrebbe la nostra Costituzione ,
non può essere fondato sulla libertà, sui diritti umani, sulla democrazia e
tanto meno sul Vangelo. Noi lo chiamiamo denaro, Marx lo aveva chiamato “il capitale”;
ma anche Draghi, e i Trattati europei che lo hanno liberalizzato, lo chiamano
così. Ma siamo sempre lì. Non è possibile, non è umano un mondo organizzato dal
denaro, così come non è possibile, non è umano, un mondo organizzato dal
capitale. L’Europa la
cui Costituzione oggi è il denaro, è Maastricht, è il Fiscal
Compact, è il 3 per cento che non si può oltrepassare, come il confine del sancta sanctorum, se si supera il quale
si muore; l’Europa del denaro e dei diritti inviolabili del capitale, non è
l’Europa dei popoli, non può essere l’Europa che fa cadere le barriere, che si
pente di Lampedusa, che rinuncia a trasformare l’ospitalità in un crimine.
Quando si sta
in mezzo al mare, su un barcone che affonda, il denaro non serve più, non
governa niente, non salva nessuno, anzi è l’ultima maledizione perché senza il
denaro del pedaggio su quel barcone non ci si sarebbe mai saliti. Però serve
l’umanità, serve il diritto, serve il lavoro, serve la politica, serve il
riconoscersi tutti come membri dell’unica famiglia umana.
Questo è il
compito che la nostra età esige, che il “cambiamento d’epoca” ci chiede. Ma
dove sono i soggetti della liberazione? Non lo sappiamo. Però almeno questa
volta qualcuno ci dice che Dio non è contro di loro.
[1] Si tratta del San Lorenzo
venerato a Roma ,
martire nel 258 durante la persecuzione ordinata dall’imperatore Valeriano. La
tradizione vuole che richiesto di consegnare entro tre giorni i tesori della
Chiesa per aver salva la vita, si presentò con un corteo di poveri; il 10
agosto, quando per questo fu ucciso, è
il giorno della sua festa.

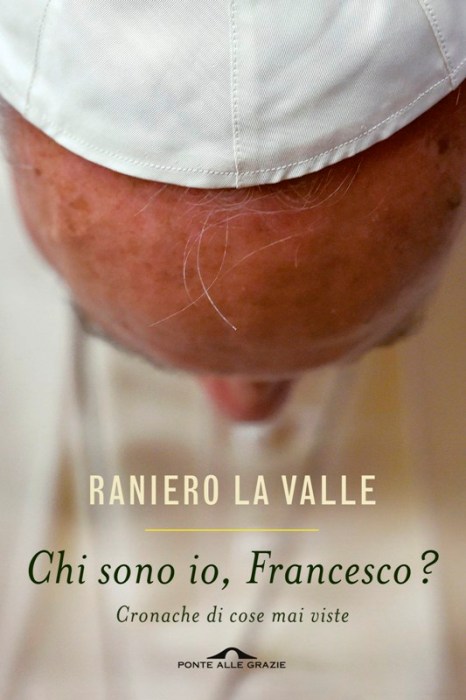


Nessun commento:
Posta un commento